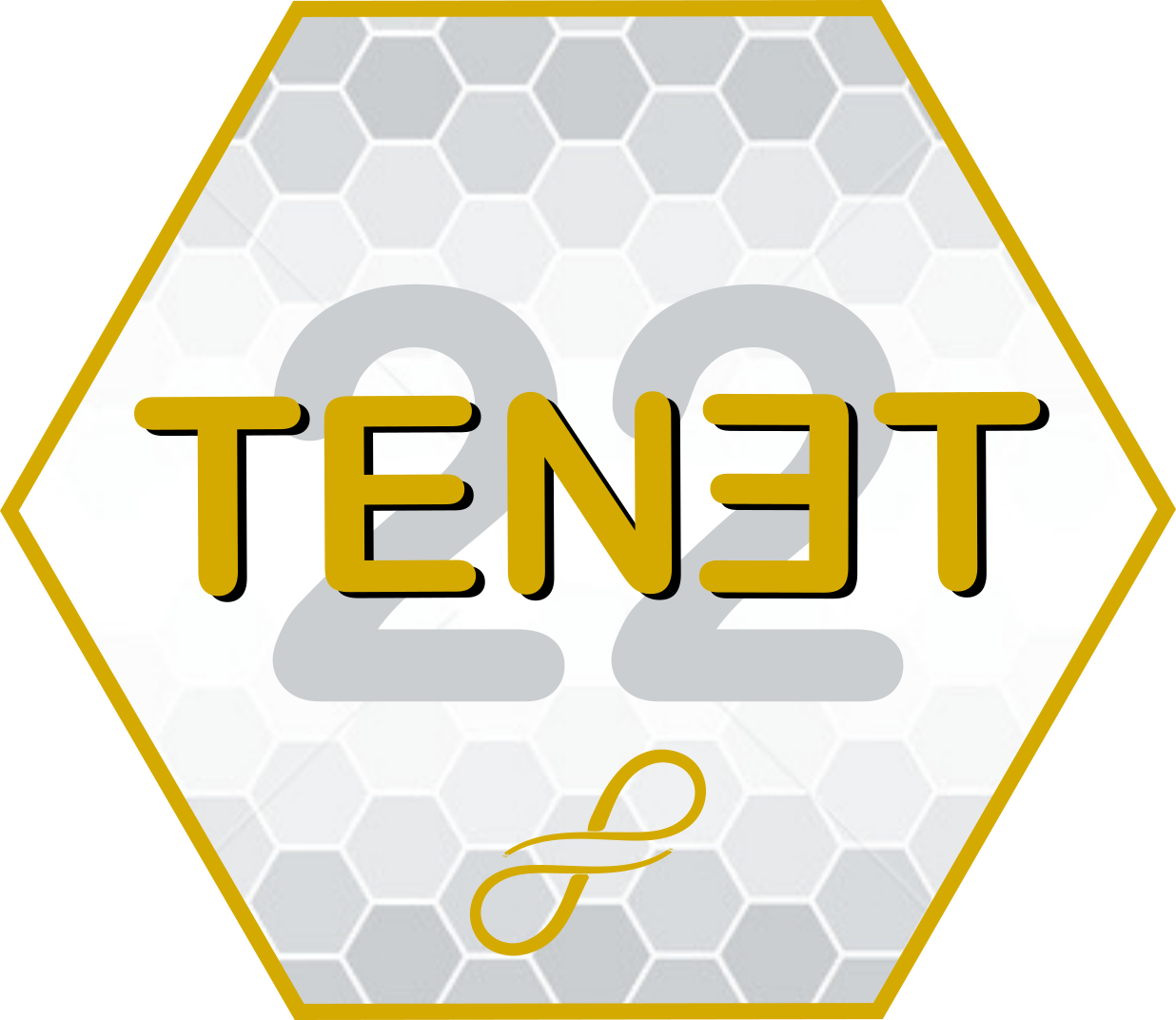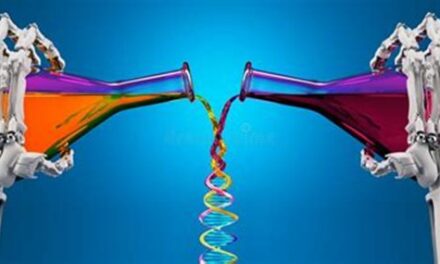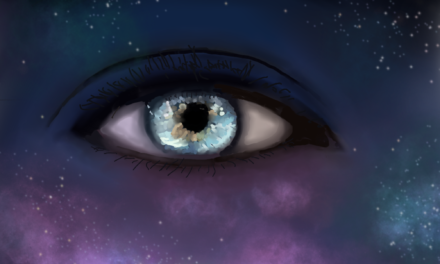Trenta anni fa “Tartaria” era per me solo un nome misterioso che rimandava a racconti come Il Deserto Dei Tartari di Dino Buzzati… e a quel soldato, Giovanni Drogo, spedito su un forte ai confini del nulla col suo piccolo plotone. Una specie di Aspettando Godot all’italiana in forma di romanzo, con un tenente che finisce per innamorarsi della sua solitudine e dell’attesa. Un nemico mitico solo immaginato e mai visto e poi la graduale perdita di interesse per il ritorno alla vita civile, fino alla malattia e alla morte “in trincea”….. Splendido!
Poi però, in una piccola trattoria sul porto di Gabicce una sera d’inverno in cui cenavo da solo, incontrai il vecchio malandato Alvise, che mi colpì subito per essere un poco alticcio e per la coltissima e potente loquacità.
Le locande dei borghi costieri, che in estate si riempiono all’inverosimile di turisti balneari, in inverno sembrano sempre sguarnite. Gli avventori hanno aspetto di reduci, qualche “ex birro da spiaggia” mal stagionato, qualche albergatore o bagnino scapolo e panciuto, qualche pallida coppia di turisti “fuori stagione”. L’atmosfera è infinitamente più bella e stimolante che in estate, perché è intima e muove alle confidenze e ai racconti: ogni tanto il cuoco viene fuori a scambiare due chiacchiere o a mangiare a un tavolo fra gli altri, ogni tanto la cameriera racconta qualche aneddoto e ci si dà del tu anche tra estranei, senza un motivo preciso, forse appunto per quel senso di precarietà o di smobilitazione.
Io, quella sera, avevo con me e posato sul tavolo un libro strano, con il nome dell’autore che sembrava un errore di stampa: E. Abbott Abbott, e il titolo Flatlandia (che uno potrebbe tradurre in italiano con “terra piatta”).

Alvise dopo aver dato spettacolo per un po’ tra una pietanza e l’altra con aneddoti e citazioni latine, venne verso il mio tavolo e indicandolo e poi prendendolo in mano mi disse: questo prete aveva del talento!
La cosa mi stupì, ricordo, perché pensai che, anche se ci fossimo trovati nella buona stagione quando la riviera si riempie di turisti, se avessi condotto un’indagine avrei trovato forse non più di due persone che sapevano di cosa si trattasse……e uno, questa sera, era qui. Così mentre Alvise se ne tornava a prendere il suo fiasco e un bicchiere per venire a sedersi con me (senza alcun mio invito) io ne approfittai per dire due parole su libro e autore.
Il reverendo E. Abbott Abbott era un erudito londinese che alternò la teologia a svariati altri interessi. La sua opera complessiva non è di valore eccelso tranne che per un volumetto dove egli affronta il tema delle dimensioni del mondo attorno a noi: Flatlandia, appunto, che vide la luce alla fine dell’800. Il suo autore vi immagina una vita fantastica fatta di linee, tratti, segmenti di linea, e figure geometriche piane… e come linee descrive, da buon uomo di chiesa, le donne, creature a suo avviso sprovviste del senso della complessità. Come triangoli i gradi della popolazione meno abbienti ed evoluti, poi a mano a mano che si sale (lungo gerarchie culturali e nobiliari) figure sempre a più lati come quadrati, pentagoni, esagoni e via di seguito. In questo mondo a due dimensioni, rigidamente ripartito in classi, un giorno farà irruenza una sfera e sarà lo scompiglio più totale per tutti perché inaugurerà la possibile
esistenza dei Poliedri.

Questo libretto, che non è certo un capolavoro della letteratura mondiale, interessa di solito gli studenti dei primi anni di matematica o fisica all’università, perché dimensione dopo dimensione pare evocare il passaggio alla “quarta” e alle ulteriori, a quelle che noi non percepiamo ma immaginiamo come forse possibili.
Ricordo che quando Alvise ritornò mi chiese il perché dell’interesse (tra i miei altri) del libro di un prete-scienziato che egli aveva letto in lingua originale negli anni cinquanta.
Risposi che mi pareva che il pensiero che lo sorreggeva fosse lo stesso che aveva guidato la mano dell’incisore olandese Maurits Cornelis Escher, le cui tavole sciolte avevo con me assieme a molte altre e stavo studiando per una mia particolare ricerca di quel periodo.

Le mie parole dovettero colpirlo particolarmente regalandogli uno scatto di lucidità, come succede agli avvinazzati cronici. Mi fissò a lungo con interesse.
Io mormorai tra i denti: e chi credevi di trovare? Un figlio di albergatore o di bagnino… o un turista fuori stagione?
Dovette afferrare il senso del mio sguardo…. si mise comodo e allungò le gambe.
Mi credi lettore se ti dico che a quel modo iniziò una delle chiacchierate (monologhi) più interessanti, panoramici e inusuali della mia vita? Una chiacchierata del vecchio che si protrasse fino all’alba, durante la quale tra credibili e incredibili appresi una montagna di notizie e la cronaca di una fortuna sperperata in viaggi di ricerca e in alcool….in donne non so. Non ne parlò. Ma non mi parve omosessuale, forse era di quelli che non si legano mai a nessuno, che coltivano la propria solitudine come un dono, ne ho conosciuti diversi.
La sua famiglia di grandi possidenti terrieri era di quelle parti. Lui era nato a Urbino ma aveva studiato a Venezia, la città di sua madre, fin dal liceo e poi ai tempi dell’università aveva preso a girare il mondo. Era appassionato di storia antica, di archeologia e culture lontane dalla nostra, godeva di una memoria prodigiosa, parlava perfettamente cinque lingue tra cui il cinese e non si era mai laureato.
Era tornato a una piccola casa rimasta di sua proprietà alla baia Vallugola, lì vicino, perché non stava bene, sentiva che il suo tempo volgeva al termine. Così di pomeriggio restava seduto di fronte all’Adriatico, mi disse, bevendo vino dolce e bianco e ripensando al Sudamerica o all’Oriente. E di notte (siccome soffriva d’insonnia) andava per locande fino a quando coi primi radi bagliori i pescherecci non prendevano il largo di là dal porto. Quello era il momento di provare a tornare a casa per qualche ora di sonno.
Per quanto riguardava la faccenda del rapporto tra Abbott Abbott ed Escher, di cui conosceva l’opera, mi disse, di voler capire meglio.
Allora estrassi da una piccola cartella alcune riproduzioni fotografiche di stampe e, nella luce fioca della locanda, iniziai a raccontare.

— Tutta l’opera di Escher, se la osservi bene, è figlia di Flatlandia. L’olandese geniale deve avere a lungo meditato su quel libretto già prima di partire per la nostra Italia. Certo in Italia Flatlandia la ritrovi inscritta costantemente nel paesaggio. Hai mai pensato che tutta la nostra architettura, da Roma in poi, sia solo un tentativo di geometrizzare la natura?
Annuì.
— Piazze lastricate, vie selciate, mura perimetrali, torri, rocche, palazzi… Io mentre mi muovo per l’Appennino mi trovo spesso, di zona in zona, a constatare dove l’esperimento è riuscito meglio e dove peggio. Te ne accorgi per una sorta di benessere o di malessere degli sguardi che a volte sembrano cogliere come un buon ritmo, una sorta di dialogo fertile tra vigore spontaneo della natura e pensiero geometrico umano. Una cosa che si fa devastante in ogni area industriale e nelle periferie di ogni città. Il nostro Montefeltro di borghi su picchi, invece, gioca il rapporto con sapienza e ritmo e mantiene una sua eleganza e dignità.
— Francesco di Giorgio Martini non era un fesso, disse Alvise, il Montefeltro è Toscana adriatica.
Capii che mi stava seguendo perfettamente.

— Bene, Escher geometrizza la natura e lo fa partendo dal Piano. Penso che la sua capacità di dare senso sia alla figura che allo sfondo non abbia uguali nell’Arte Occidentale. In lui ogni scacchiera porta un senso e il modo di intersecarsi delle geometrie e delle figure genera costantemente un lieve capogiro per quel suo togliere a ogni tavola il concetto di centralità. Se lo sfondo riveste il medesimo valore della figura, ecco che non sai più dove focalizzare l’attenzione, e la realtà diventa onirica e in luogo di un significato tradizionale inizia a valutare il peso degli spazi (che si fanno concavi o convessi) e mostrano (proprio come insegna il geniale Reiman nelle sue ipotesi su geometrie non euclidee che dovettero intrigare non poco sia il reverendo londinese che lo stampatore olandese) di contenere dimensioni non sospettate, che vanno ben oltre la terza. Escher crea incastri sul foglio che la realtà di terza dimensione non contempla e non pare riuscire a contenere, per questo nelle sue tavole pare nidifichi l’infinito.
Alvise, notai, mi aveva ascoltato attento, ma mentre mi apprestavo ad approfondire prese la parola:
— Forse non sai che ad ispirare Escher, dell’Italia non fu soltanto il paesaggio (che proprio come dici è un costante dialogo tra geometria e natura e là dove gli equilibri sono buoni genera un senso di armonia che emoziona!) ma anche un incisore che aveva un genio non
inferiore al suo: Giovan Battista Piranesi!

Da questo punto in poi il vecchio coltissimo ubriacone non mi lasciò più la parola e in un profluvio di ricordi, di incontri e viaggi e ricerche, mi raccontò la sua vita in una notte.
Io, del resto, pur avendo capito dove abitava, me ne guardai bene dal ricercarlo dopo quell’incontro. Venni a sapere che era morto due anni dopo. E che aveva chiesto di esser sepolto in un cimitero veneziano. Venni a saperlo dal gestore in quella medesima locanda, in una sera d’estate in cui era strapiena di turisti.
Ma il fatto è che, come dice il proverbio, “il troppo stroppia” e io all’alba mi sentivo “stroppiato”.
Per non offrire anche a te, o lettore, quel senso di spossatezza e sfinimento che prese me all’alba, approfondisco solo un capitolo fra i molti che mi espose: quello sulla Grande Tartaria.

— Di Piranesi sentii parlare per la prima volta a Venezia, nella bottega di stampe e libri di un erudito ebreo del quale mi ero fatto amico, Yossef.
È stato quel geniale ebreo (finito ad Aushwitz) a raccontarmi che nella vita un conto è leggere le storie e un conto è verificarle di persona. E che nulla è come sembra di quello che conosciamo, perché sopra la massa infinita della gente c’è sempre stata una élite di nobili, ecclesiastici e banchieri, che puoi assommare a poche decine di dinastie e che, camuffandosi mille volte in mille contesti, sono rimaste sempre le stesse e, in alleanza con esseri demoniaci a cui hanno ceduto l’anima, hanno distorto ogni verità di cronaca e ogni narrazione per non soccombere, per sopravvivere ai mille rivolgimenti della storia!…..le famose “linee di sangue” che dal buio comandano la storia, non sono una leggenda, transitarono e transitano per queste nostre terre!
Yossef aveva molte incisioni del Piranesi nella sua bottega e passare i pomeriggi in sua compagnia era un incanto. Faceva la spola tra Venezia e Roma per i suoi traffici di libri e stampe, e il lungo contatto con prelati e nobili delle due città lo aveva erudito su una quantità di fatti narrabili ed inenarrabili. Fu solo quando si avvide che, nonostante l’età acerba, la passione per l’arte e la conoscenza erano autentiche e solide in me, che prese a parlarmi in piena libertà.
— La città dei papi e la città dei dogi (pochi lo sanno) sono gemellate da sempre nel mondo dell’occulto. Questo per avere allevato “attorno alle due dinastie di regnanti più potenti e longeve d’occidente” una valanga di parassiti.
Con un termine medesimo “nobiltà nere” vi si designavano tutte quelle famiglie che papi e dogi avevano fatto aristocratiche e arricchito a dismisura. Quelle famiglie che, con la nomina di nuovi papi o nuovi dogi, non erano certo disposte a perdere privilegi, cariche e potere, inventandosi o riscoprendo genealogie di origine romane o bizantine dei tempi imperiali, credevano di poter godere in eterno dei proventi della beneficenza o dei traffici per mare, e a quel modo costruirono il più potente apparato di corruzione che la storia ricordi. Una serie di scatole cinesi o di società segrete annidate dentro società per controllare traffici di indulgenze, prestito ad usura e ruoli di potere occulto, in ogni angolo di mondo.
Si servirono di ordini religiosi, viaggianti come i gesuiti, logge rituali sopra nazionali e matrimoni concordati, per giungere dove altre imprese mai erano giunte e, per chi non ne sa nulla, cosa difficilissima da credere, decidere tutte le guerre e le rivoluzioni più importanti sulla terra.
Mussolini, il pettoruto Mussolini che in quegli anni spadroneggiava parlando di imperi in allestimento dai balconi romani, non era in fondo (come del resto Hitler) che un pagliaccetto in mano loro e di loro creazione.
Mi credi se ti dico che dai miei viaggi e incontri a ogni livello non ho fatto che avere conferme a queste parole dell’ebreo Yossef? Ma sarebbe un discorso lungo da fare!
Uno che queste dinamiche le aveva capite alla perfezione fin dal settecento (anche se ce ne ha parlato in modo ermetico) è stato proprio il Piranesi. Il grande Giovan Battista, che si era formato a Venezia per poi approdare a Roma.

Vi sono certe sue tavole che Escher deve avere guardato mille volte. Vi sono nelle sue cosiddette “Prigioni” e “Rovine“… (adoro questo modo di affrontare un tema e svilupparlo in ogni forma possibile per tavole e tavole) alcune che affrontano lo spazio proprio come l’incisore olandese. Creano strutture che diventano guide per l’occhio di chi le scruta attento, e lo conducono in prospettive impossibili e labirinti che sfidano la logica, così facendo enunciano, come Escher e prima di Escher, dimensioni ulteriori oltre le tre che sono note a noi mortali. In Piranesi si viaggia sempre dal reale al sogno ma egli lo fa non solamente per fini conoscitivi, ma anche e soprattutto “morali”. I suoi due filoni principali, ti dicevo, sono quello delle Prigioni……una sorta di grotte sotterranee a più livelli che, a prima vista, guardi a lungo senza riuscire a comprenderne il senso o la natura poi, sfogliando più di una stampa e tornando alle precedenti, ti accorgi che pur gigantesche sono sempre comunque luoghi di cattività, luoghi claustrofobici che non percorri con gioia e aspettative, antri di labirinto che corrono in ogni direzione senza portarti da nessuna parte, scale a rampe che salgono e salgono, e terminano in un soffitto. Minuscole e magiche presenze semi umane che scopri qua e là, ti rincarano la dose di ansia da soffocamento come in quelle grotte che scopri popolate di radi pipistrelli.

Un sognare che si fa incubo o coazione al ripetere di stesse scale e stessi corridoi e orme di prigionieri che avverti presenti, anche se non sai dove, forse dormienti in recessi in ombra. Il pensiero corre inevitabilmente al mito platonico della caverna e a volte ti viene proprio da distogliere lo sguardo dal disegno, guardarti alle spalle come in cerca di una via di fuga o di una boccata d’aria.
L’altro ciclo di stampe ha per titolo Rovine ed è non meno sorprendente e inquietante del primo.

Come nel primo ti assale un senso di ansia e sproporzione, e qui anche di nanismo, tuo di spettatore, di fronte ad edifici che scopri troppo grandi per te e poco abitabili e poco comprensibili per chiunque. Quegli edifici che a volte percorriamo vanamente nei sogni senza approdare a una meta, senza trovarvi anima viva, senza sapere perché vi siamo entrati. Rovine gigantesche di imperi scomparsi che solo in parte sono Roma, resti ben più misteriosi o remoti, inabitabili, impercorribili e inquietanti.
La grandezza qui come elemento di straniazione e non di meraviglia, come una lingua che non hai mai sentito e che non sapresti mai tradurre.
Ecco il fascino ombroso di Piranesi è tutto qui!
Da un lato la consapevolezza (raggiunta dalle sue altissime frequentazioni in circoli segreti di iniziati del Vaticano) che il mondo è da sempre “una labirintica prigione” riservata al popolo, come voluto dalle cosiddette élite nobiliari religiose. Dall’altro, il venire a sapere che ogni civiltà cresce sulle rovine di una precedente, e che i nuovi sistemi politici cercano sempre di cancellare la memoria dei precedenti, soprattutto se si trattava di sistemi infinitamente più avanzati e liberali…..e la civiltà di grandi rovine cui Piranesi allude è quella di Tartaria.
Furono chiacchierate simili in compagnia dell’eruditissimo Yossef — disse Alvise — a instillarmi il germe della ricerca.
Partii e viaggiai molti anni, non solo per sottrarmi alla dittatura fascista ed all’imminente guerra già perduta in partenza, ma per capire cosa fosse stata davvero la Grande Tartaria. Tu considera che Yossef, di antica famiglia ebraico veneta, non era mai andato altrove che lungo la tratta ferroviaria Venezia-Roma. Tutto quel che sapeva, lo aveva appreso dalle sue smisurate letture, dai colloqui con professori che lo venivano a trovare alla bottega e da certi Cardinali romani suoi affezionati clienti, forse dissidenti rispetto alla politica papale.
Quanto Yossef avesse ragione nelle sue affermazioni e indagini, io lo compresi anni dopo quando, con documenti da me abilmente falsificati, dal Tibet riuscii a penetrare prima in Cina poi in Russia.
La grande muraglia era detta “cinese” per errore. In realtà non serviva a difendere la Cina ma a difendere, dalla Cina, la Grande Tartaria, il cui nucleo principale era situato tra Siberia e Mongolia. Le porte, i camminamenti e i potenti merli, posti ad Occidente, riparavano dal lato d’Oriente. Questa cosa che mi aveva detto l’ebreo, potei verificarla sul posto.

Quel che fu la grande civiltà tartarica io lo appresi da Yossef e dai monaci del Tibet. Ma lo verificai viaggiando di persona, certo, raccolsi indizi e rade prove. Raccolsi quello che la grande consorteria di cui ti ho detto prima non era riuscita ad occultare, a far scomparire dalla faccia della terra.
Ma poi la Grande Tartaria che cosa era stata?
Un monaco buddista mi disse: una civiltà fantasmatica, un’accozzaglia di popoli e civiltà venute da lontano, da molto lontano, ma che in prima istanza approdarono a Nord della nostra Terra.
La povertà della cultura materialista e occidentale parla della nostra Terra come di un pianeta che è il solo abitato in tutto l’Universo. Un pianeta su cui dimora un essere che, evolutosi dalla scimmia, avrebbe fatto spontaneamente carriera popolando i continenti e sottomettendo ogni altra specie di animali e piante. Che povertà di approccio, che egocentrismo, che stupidità!
Sono centinaia le specie di umanità che sulla Terra, dai miliardi di anni in cui è abitabile, sono arrivate da altre regioni di Universo a provare l’esperimento della vita……o meglio….è infinito il numero di anime (mi disse il monaco) che, nelle varie ere della terra, hanno scelto di incarnarsi nelle umanità che qui han dimorato e che han dato luogo a plurime civiltà. Le più note, quelle che nei grandi registri dell’Akasha hanno lasciato le tracce più marcate, sono la
razza Polare, l’Iperborea, la Lemuriana e la Atlantidea.

E le civiltà che sono riuscite a trascendere la materia hanno finito per farsi angeliche e libere, mentre quelle che non ci sono riuscite, sono rimaste schiave delle passioni e dei demoni che le amministravano.
Bene, Atlantide che in una fase della sua storia fu gloriosissima e si espanse in ogni angolo di globo, non riuscì poi nella sua maturità a liberare la spiritualità dal giogo delle passioni e fece pessimo uso delle grandi conquiste raggiunte con l’ingegno, giacché l’ingegno si muove svincolato dalla moralità.
Ma gli atlantidei non erano un popolo compatto. All’interno di quella civiltà si muovevano sette di genti purissime e redente che con la grande inondazione (predisposta dalle più alte gerarchie del cosmo) furono portate in salvo, chi nella Terra Cava, chi in luoghi appartati e altissimi del Tibet, delle Ande, del Nordamerica.

Ma fu da comunità misteriose venute da non si sa dove che partì una nuova civiltà globale, detta Tartaria, che la Storia Occidentale volutamente ignora, forse perché ammetterla vorrebbe dire di non essere mai stata l’unica civiltà presente sul pianeta e avere convissuto con razze differenti e molto più evolute?
Alla fine degli anni cinquanta dal Tibet (dove avevo appreso la vera storia della Tartaria, della colonia dei popoli Arij di Aldebaran, che da eoni viveva indisturbata in una città intra terrena sotto al prodigioso monte Kailash, e dalle bocche polari di ingresso alla sconfinata variegatissima Terra Cava e a Shambhala) riuscii a entrare in Cina e a raggiungere i gelidi confini con la Russia.
Che spaventoso stupore mi assalì nei giorni in cui con le mie guide riuscii a visitare due immense città del tutto abbandonate non troppo lontane una dall’altra!
L’opulenza deserta dei palazzi, delle vie e delle piazze che parevano sconfinate oltre il senso che si può attribuire a questa parola, non aveva nulla a che vedere con l’architettura delle città cinesi che crescevano come funghi in quel dopoguerra e che al confronto apparivano misere topaie.
Palazzi di sei o sette piani, dalle finestre e dalle porte attraverso le quali potevano transitare esseri giganteschi, lampioni di altezza e foggia mai vista, pietre selciate larghe come stanze.
Restammo a lungo a percorrerle fermandoci sotto porticati o al margine di piazze. Neanche un gatto rinselvatichito o un cane randagio attorno a noi. Un deserto che incuteva spavento. Ecco, eravamo capitati in una prigione del Piranesi, una prigione a cielo aperto che però sotto un cielo plumbeo che gravava su un paesaggio piatto e senza limiti, comunicava lo stesso senso di claustrofobia. Non erano rovine attorno a noi. L’ambiente poteva essere stato abbandonato da dieci anni o da un secolo, non si riusciva minimamente a capire quando. Solo in un quartiere trovammo delle rovine, ma non naturali, come un principio di demolizione. Una delle guide mi disse che era in progetto la completa demolizione di tutte e due le città per riciclarne i preziosissimi materiali, come per altre città simili a queste che erano in territorio sovietico ed egli aveva visitate.
Poi fu proprio parlando con un dissidente russo che incontrai anni dopo a Parigi che compresi quanto il commerciante di stampe ebreo avesse ragione e sapesse più cose su quelle città e sulla cultura che le aveva erette.

Sì, erano Città Tartare! Erano state, un tempo, assai popolose. Non una civiltà ma più specie etniche e culture componevano lo sconfinato tessuto dell’impero tartaro. Un impero che aveva propaggini in ogni continente e che essendo infinitamente più progredito in tecnologia e in spirito di noi, tollerava la presenza sulla terra della specie homo sapiens, come noi tolleriamo la presenza dei topi (a patto che non fossero troppo numerosi o infestanti).
Nelle loro città (così anomale rispetto alle nostre perché popolate di esseri che raggiungevano spesso i tre metri d’altezza e che convivevano pacificamente con razze che noi avremmo considerato affette da nanismo, che si aggiravano attorno al mezzo metro di statura) l’energia era frutto dell’etere, illimitata e gratuita, l’essere carnivori era considerato il peggiore dei peccati perché gli animali godevano degli stessi diritti dell’uomo, e lavorare era facoltativo perché una dignitosa sopravvivenza era garantita, per statuto, a tutti.
Noi, homo sapiens, sapevamo poco o nulla di loro (una colonia di scimmie, se interrogata sull’umanità, che cosa può dire?). Riuscivamo a provare solo un timore vago e sacro (mirabilmente descritto da Buzzati – scrittore veggente – nel suo racconto).
Loro invece vivevano in un mosaico di più specie e avevano colonie di eguale composizione in Africa, Europa, America del Sud e del Nord. Io, durante i miei viaggi in ogni continente, ma soprattutto in America Latina, in città antiche e insospettabili, ho trovato ancora alla metà del secolo palazzi che, per dimensione e fattura, parevano “buoi in greggi di pecore”, che se ne stavano immotivati tra gli altri: semplicemente irrelati e abnormi, alcuni poi demoliti, altri trasformati in strani monumenti.
Poi però accadde un evento (che a livello planetario si definisce “stancamento di una civiltà”). L’ozio, la vita facile e forse la noia di chi crede di aver raggiunto la perfetta padronanza della sorte fu il germe che li contagiò.
In luogo di una costante ricerca di ascesa spirituale si sedettero e si dettero a giochi edonistici di varia perversione. Le loro anime si compiacquero del soggiorno nei loro corpi e smisero di agognare alla trascendenza. Fu allora che si fece chiaro in loro lo scarto fra tecnica evolutissima e trascurata spiritualità.
Pochi di loro si accorsero dell’immane pericolo di una deriva simile e si ritirarono in luoghi isolati ed eremitici per salvarsi dal contagio.
Fu questo che rese i Tartari simili agli Atlantidei: infinitamente vulnerabili.
Poi le campagne di conquista di Napoleone in Russia e degli Inglesi e Spagnoli nelle Americhe, furono solo un assecondare lo spirito dei tempi, eliminando i Tartari sopravvissuti, riciclando e camuffando i materiali della loro poderosa civiltà.

Da qui tutte quelle foto dei secoli scorsi che appassionano gli intenditori e testimoniano di oggetti e palazzi ed esseri “non proprio umani”.
Materiale da guinness dei primati, strane cartine geografiche, diffuse anomalie architettoniche, bizzarrie degli esseri e del tempo, che le élite politico religiose occidentali, cercarono come poterono di far scomparire dalla faccia della terra, in nome di una goffa e presunta nostra unicità.
Non ci riuscirono. Chiaramente non riuscirono a prendere il comando dell’intero globo uniformandolo ai propri dettami. Certo, dover ammettere, per queste persone ricche di beni materiali e poverissime di spirito, che vi sono state fino a ieri civiltà più evolute della nostra è cosa dura. Così come sarà un duro colpo da digerire il fatto che la terra è soggetta a ripetuti reset, più o meno violenti….e che si avvicina il reset dell’umanità homo sapiens, la nostra.
Un reset che come per gli atlantidei e i tartari, boccerà tutte le élite più tre quarti dell’umanità. Quell’umanità sciocca che ha creduto che, una manica edonista di nobiltà farlocche, di prelati avidi e di banchieri truffaldini, operasse da sempre per il bene di tutti. Sciocchi uomini-massa e portaborse che hanno sempre obbedito senza mai dubitare, anzi, imitandone le mosse e che è giusto che facciano la fine dei loro padroni.
Questo mi disse il vecchio e coltissimo ubriacone in una notte. Certo, mi disse anche molte altre cose, Alvise il giramondo nato a Urbino e sepolto a Venezia. Ma questo episodio di Tartaria, una civiltà che visse sulla terra e poi dileguò nell’ombra del tutto ignorata dall’Occidente, era un tema per me davvero sconosciuto, un tema che riporto perché, di questi tempi, mi pare a suo modo esplicativo.
Anche se sul reset io sono molto più ottimista di Alvise, perché ho visto che è molta la gente che si è destata in questi anni, che cambia vita e non crede più alle vecchie gerarchie, alle baggianate di tv e giornali (nella quasi totalità super corrotti e pieni di portaborse ben compensati) che cercano ancora di dare ad intendere, ai fessi che li consultano, un mare di scempiaggini!
PS
Sulle scorte di Alvise ho continuato invece ad approfondire negli anni i lavori comparati di Piranesi ed Escher. Ne ho ricavato una serie di lezioni per alcuni amici francesi di buon ingegno innamorati della nostra Italia.
Seminari e studi li portai avanti mosso della passione che mi ha sempre accompagnato per le scoperte di Padre Ernetti, che fra l’altro, egli aveva conosciuto di persona, e sul quale mi raccontò particolari davvero sorprendenti!

Ora mi pare prematuro avanzare ipotesi, ma se considerati in una certa ottica, penso non sia eccessivo affermare che i due grandi incisori erano di quegli strani esseri che in inglese son chiamati “time-traveller”, e che le loro tavole (o almeno alcune di esse) sono cartine di tornasole o traduzioni spaziali cifrate di quei viaggi. Da qui certi lemmi figurativi che ritornano in entrambi, e certe, come dire, trappole per l’occhio, trasgressioni visive, inganni ben calcolati della vista.
Ci torneremo!